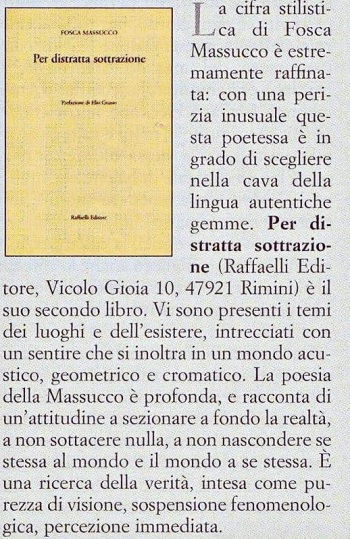Daniela Pericone su Capoverso n.31 Gennaio-Giugno 2016 – recensione a “Per distratta sottrazione”
![]()
Clizia E. Guerrini su NAZIONE INDIANA – recensione a “Per distratta sottrazione”
Il secondo libro di Fosca Massucco, dopo L’occhio e il mirino del 2013, si presenta con una grande apertura verso il territorio abitato dall’autrice: il Monferrato di Beppe Fenoglio, da sempre letto e riletto con incondizionato trasporto. Le impostazioni metriche da lei usate hanno l’andamento lirico di certe pagine di Una questione privata, quando nell’uno e nell’altro caso la poesia si spalanca alla luce perfetta di quelle colline. Ci sono segni del territorio natìo e precisioni scientifiche che fanno pensare a folte letture zanzottiane, anche se non sono particolarmente d’accordo con Elio Grasso, in sede di prefazione, quando avverte che l’opera del poeta di Pieve di Soligo potrebbe condurre Massucco a prove future ancora più profonde e salde. A me pare che possano essere differenti, e altrettanto importanti, i percorsi da affrontare e fare propri. Senza escludere, come suggerimento non casuale, il Sereni del Posto di vacanza. Non fosse altro che per le avvedute attenzioni verso la realtà, dei luoghi e dell’anima, e per le robuste abilità prosodiche. Le tre poesie, successive al libro, e recentemente pubblicate nel terzo Almanacco della poesia edito da Raffaelli sembrano confermare, nella loro tempestiva luminosità, questo mio pensiero. Forte delle sue competenze tecniche e scientifiche (l’autrice ha una laurea in Fisica e lavora come Tecnico del suono) i temi della raccolta vengono sviluppati secondo linee di conoscenza religiosa, uno spartiacque tra la visione per così dire esteriore del paesaggio e quella interiore dell’anima. La scansione delle sezioni rivela chiaramente come a Massucco interessi prima di tutto lo studio dei particolari nei testi sacri, e il metodo più conveniente a trasportare nella propria visione quotidiana il ricco fiume ideologico e devozionale. Immergendoci nelle pagine di Per distratta sottrazione si avverte una responsabile e autonoma volontà di ricerca, ogni premessa viene portata a compimento sia sotto forma di luce diretta sulle personali visioni sia sulle corrispondenze trovate nei prediletti autori. Questi non vengono mai citati, ma la sintonia del libro vale per la raffinata annessione che si avverte e di cui, mi sembra, si possa godere. Da un capo all’altro dell’opera, sorvolando la fin troppo estesa Prefazione, annidamenti e svelamenti conducono alla nobilitazione di quanto oggi cerchiamo nel vasto e controverso mondo della nuova poesia.
Plinio Perilli su “GRADIVA” International Journal of Italian Poetry – Number 48 – recensione a “Per distratta sottrazione”
Cuneese del ’72, laureata in Fisica e specializzata in Acustica — recita la nota bio-bibliografica, «vive su una collina del Monferrato astigiano». L’incipit memoriale è dunque intrigante, così come l’ossimoro, o meglio l’allitterazione concettuale di questa sua seconda prova poetica, distratta sottrazione: «È la rabbia che fa maledire la terra / sotto la quale si dimora. Fermami / se puntuale scaccio la grazia — cacciami / al fondo delle ripe». Finalmente una creatura poetessa che osi uscire dai melliflui stereotipi di finta dolcezza, Dafne pudibonda, troppo spesso recitata venustà di petali e rose porporine, per invocare e dedicarci «braccia di rovo», rabbia malefica, una grazia dannata e terrestre… Lo scenario è ventoso d’espressionismo, scabro, incupito d’eventi, grandi o minimi è lo stesso: chicchi franosi, memoria distratta di materia, altèra gramigna di massicciata, un filare di tralicci… Ma questo sfondo purgatoriale e sdivinato di natura, meglio la riconsa-cra, ci incorona all’umano come equazione tra Suono e Pensiero, cliàpason forse d’assoluto: «Il dolore è silenzio del tono puro / per distratta sottrazione».
Fabio Simonelli su POESIA n.311 di gennaio 2016 – recensione a “Per distratta sottrazione”
La nuova raccolta di Fosca Massucco – la seconda dopo L’occhio e il mirino, uscita nel 2013 per le edizioni L’Arcolaio, prefazione di Dante Maffia – è accompagnata da una magistrale introduzione di Elio Grasso, che,volando fra testo ed extratesto con profondità e leggerezza, maieuticamente si chiude con la stessa domanda del libro: «…ora che ogni voce tace/ quale rifugio darò alle mie parole?». Per l’autrice, fisica ed esperta di acustica, il suono (anche quello della parola poetica) non è un semplice mondo d’impressioni soggettive: è vita ed esattezza, tramite fra materia ed energia, dentro e fuori, senso e verbo. Il suono – non certo per “natura”, ma secondo l’osservatorio del nostro corpo, che in fondo è una cassa di risonanza fisica ed emotiva – è forse ciò che possiamo chiamare antecedente alle distinzioni artificiose fra materia e spirito: dicotomie metafisiche, pericolose per il sentire sano della poesia. Qui, se mai, il suono è anima universale; musica delle sfere, scriverebbe Platone – non a caso, «l’anima sale così in alto/ da suonarsi da sola le campane» (p. 54).La vita è baccano zittito dalla violenza di un colpo di fucile che «rimbalza – muore» (p. 29) e non uccide soltanto il fagiano, ma l’ordine naturale delle cose, difficile da cogliere proprio perché disturbato.Attorno c’è un silenzio pieno di crepe, in cui s’intrude la cosiddetta realtà, che minaccia e insieme definisce lo stato di concentrazione, quello «sforzo sublime» cui la mente sempretende. È questa una poesia piena d’attenzione, intesa nel significato etico caro a Simone Weil, sinteticamente rievocatain un verso suggestivo: «l’attenzione – la precisione/ lasciata a dio» (p. 26). Suono, con metonimica concretezza, è anche la gamma di tonalità di cui è fatta la vita, persino e forse soprattutto nelle situazioni limite, quelle che con visuale egocentricamente ridotta continuiamo a chiamare emozioni, e che sono invece vicende universali: «Il dolore è silenzio del tono puro/ per distratta sottrazione» (p.20). Di “toni puri” è materiata questa poesia: non certo per idealismo, o per la pretesa tutta intellettualistica di raggiungere l’assolutezza, ma – al contrario – attraverso l’analisi dell’esperienza umana, delle scoperte materiali, delle cose da sempre ricercate e costruite con artigianale passione per approssimarsi alla nudità del vero. A cominciare dal “giusto” della bilancia – come non pensare al giusto della vita di Luzi? – per incontrare, più in là nella raccolta, le lamelle di un metallofono, lo strumento per curare la sindrome post amputazione, i frutti pazienti della semina; nella parte centrale del libro, probabilmente il suo più alto vertice poetico, troviamo la tecnica capovolta del dagherrotipo, un algoritmo che dice sia le «operazioni di creazione», cioè il laboratorio del poeta, sia la circolarità inscindibile di vita e morte. «La mia ricerca è sempre controluce/ il rospo nella luna. Perturbo/ miserevoli condizioni al contorno – levigata dalla vita, mai vinta» (p. 33). Da una parte all’altra degli illusori antipodi, al di qua degli schemi razionali, anche la morte continua a creare. «Al camposanto il cantiere tra i cipressi/ e i tralicci è ala vergine di quiete,/ vibra le trivelle, scuote l’aria./Anche nelle bare il vuoto/è più denso delle ossa». (p.23). La “forza operosa” di foscoliana memoria, che affatica i sepolcri, non è qui semplice inerzia meccanicisticamente intesa: piuttosto, assenza di separazione fra presente e passato, fra memoria e vita, che continuamente coesistono. La poesia, come la terra, sa trasformarela morte in fiore. I versi di Massucco ce lo dicono con l’eleganza di un’equazione, con la nettezza di un chiaroscuro. Tutto il resto, direbbe Paul Verlaine, è letteratura.
Prova di lettura senza note, premesse, introduzioni, riferimenti, complimenti: cosa fa della poesia di Fosca un caso a sé, in parte già pubblico, se non la normalità? Il paradosso è che in queste poche pagine passano timbri insoliti per questa stagione. Vi abitano corvi che una antica consegna ha destinato a celebrare “l’immanenza del suono”, per poi tornare fango. Perfetto contrappunto rispetto alla concezione induista, nella quale, uscito dalla gola della Tartaruga che regge la Terra, il suono è Dio. La grazia di restituzione della poesia sta qui nella levità dell’ascolto, in una percezione insolita ma familiare. Dice quello che sapevamo già, ma non avevamo notato né espresso. Tolte le spiegazioni, tutte le spiegazioni, constatiamo che effettivamente le montagne sono masse liquide in movimento, la loro millenaria cinematica visione è perfettamente avvertibile sopra Delfi come sulle Langhe, negli invasi desertici solo immaginati come nel più anonimo rilievo. Lo scioglimento delle montagne corrisponde ai battiti di un cuore impavido, fuori dalle leggi della dinamica. Montale, Pavese, la Bibbia, la scienza supportano una poesia che li assimila per “distratta sottrazione”; e più che espunti risultano di colpo promossi a nuova giovinezza. Esistono altre giovinezze che si erano perse, finché qualcuno che non conoscevamo ci dice di “prestare attenzione ai messaggi/ ritardi annullamenti partenze” (p. 37), ci svela che esiste “il verso da cormorano del treno/ che torna e cambia la stagione” (p. 21), dipinge la rarità di un “arcobaleno di notte” (p. 19). Ecco come rinascono le vite dimenticate. Bastava, basta anche ora, l’invenzione più semplice, l’epifania conclusiva dell’io-tu: “se volessi offrirti ancora l’infinito/ io mi aprirei qui”, stupenda sintesi che ripristina il valore della soggettività. Se invece vogliamo ridare un ruolo alle spiegazioni, non resta che condividere quanto scrive Elio Grasso nella sua ponderosa introduzione: dove, fra diverse acute suggestioni, è condivisa la “tendenza amatissima … di riavvolgere la solitudine e metterla come nota a qualcosa che sia entità nuova”. Avremo occasione di riparlarne, di Fosca.
Daniela Pericone su Carteggi Letterari – recensione a “Per distratta sottrazione” – agosto 2015
“Un libro non si legge, vi si precipita; esso sta, in ogni momento, attorno a noi. Quando siamo non già nel centro, ma in uno degli infiniti centri del libro, ci accorgiamo che il libro non solo è illimitato, ma è unico.” (Giorgio Manganelli, Pinocchio: un libro parallelo). Questo tipo di considerazioni si innesca alla lettura dell’ultimo libro di Fosca Massucco, Per distratta sottrazione (Raffaelli Editore, 2015), nel sentore di averne colto il fuoco centrale ed essere subito dopo smentiti da un altro ritrovamento. Già da tali segni si individua la valenza di un testo e dalla capacità di produrre una visione, tanto maggiore quando le visioni si moltiplicano. Una sorta di geminazione che è anche gemmazione, tanto per introdurci nella sfera del linguaggio prescelto da Massucco, un vocabolario della natura accurato e specialistico, proprio di chi si è immerso in un habitat agreste per predilezione consapevole e ne ha assorbito gli elementi e la nominazione come atto d’amore e di perpetuazione.
Dalla sua “metropoli boschiva” (come Elio Grasso in prefazione ne definisce la realtà oggettuale e quindi poetica) Fosca Massucco trova una prospettiva, sia di sguardo che d’ascolto, che ne rendono viva e per nulla “distratta” la presenza, come il titolo vorrebbe – ma solo in apparenza – fare intendere. Uno dei motivi fondanti della raccolta è proprio in questa attitudine della mente, l’attenzione o il suo contrario, che in varie forme e occasioni ricorre nei versi, a partire dalla “distratta sottrazione” del titolo e della poesia che l’include, poi “memoria distratta di materia”, “fingermi senza / l’attenzione”, “è tutto un universo di avvisi”, “prestare attenzione ai messaggi”, fino al culmine di un’accezione che sembra rovesciare in modo decisivo l’assunto iniziale: “Concentrazione, sforzo sublime!”. Una congerie di tracce e possibili significati cui Massucco allude, anche e contrario, per dare corpo a un intendimento, alla convinzione che per comprendere la realtà sia necessaria una vigile coalizione di tutti i sensi e al contempo una lieve, radente, de-concentrazione, che consenta di accogliere con serena apertura la varietà di segnali provenienti dalla vita vegetale e animale, sia nel suo apice di rigoglio che nella vicenda più cruenta dei disfacimenti.
Il disordine composto della piana
nel mese mercedonio, i campi gonfi
d’acqua – un giurassico in ritardo –
la perfezione vibrante del vapore.
Nutrie indaffarate si levano sedute –
riflessi, acquitrini, ombre rapide
nei campi – lungo i fossi e nelle ripe
in vista i denti arancio, a contemplare
il mio profilo mentre guido.
Se volessi offrirti ancora l’infinito
io mi aprirei qui.
Intanto la “sottrazione” del titolo, secondo perno del sintagma, rafforza lo stigma di un atto in levare, una diminutio che riguarda il pensiero, ma anche la materia e il suono, entrambi campo di studio e professione di Massucco (in fisica e acustica la sua formazione). Si delinea un altro tema cruciale di scrittura, là dove alla privazione di materia o di suono si fa corrispondere il concetto di vuoto, convocato e affrontato con insistenza nel corso della raccolta:
Ancora pensi all’universo capovolto
dove traspare solo vuoto tra i cipressi
e la cinta delle mura? Il nulla
è immagine di sé e il vuoto
non è vuoto, vacilla in solitudine
[…]
Se ormai sappiamo che il vuoto non è realmente tale, che non esiste alcuna zona di spazio del tutto priva di forme di energia, tuttavia quello con cui ogni essere umano deve fare i conti è il vuoto inteso come inesistenza, perdita, distanza. Come fine. “Anche nelle bare il vuoto / è più denso delle ossa”. E non soccorrono a sufficienza le conoscenze scientifiche o il solo esercizio della ragione ad arginare le implicazioni dolorose: “Il dolore è silenzio del tono puro / per distratta sottrazione”.
Dolore e vuoto possono dunque coincidere e incombere in assenza di suono, pausa della voce, silenzio. Ulteriore punto focale questo, forse il più radicale, perché contiguo alle motivazioni stesse della scrittura poetica. La parola per Massucco è materia fonica, suono da trattare, calibrare, modulare, vibrazione in grado di contemperare istanza emotiva e razionale. Se la realtà tutta non è che vibrazione, la poesia diviene luogo eletto di ricerca di senso attraverso il corpo sonoro delle parole e la corrispondenza fonosimbolica dei segni.
Il linguaggio di Massucco, che attinge alla terminologia tecnica musicale oltre che alla nomenclatura del paesaggio (in un arco di relazioni da Virgilio a Montale a Zanzotto), è sempre spinto verso esiti alti e raffinati, e sottoposto a un’opera di scarnificazione continua, di “sottrazione” (ritorna il titolo come chiave di lettura imprescindibile), lavoro paziente di filatura a conciliare suono, senso e silenzio.
Alessandro Canzian – recensione a “Per distratta sottrazione” – agosto 2015
Si può scrivere così. Come si può scrivere, in modo altrettanto? Nella metropoli boschiva di Fosca Massucco, zeppa di sguardo e di passi privi di retorica, il primo radente profili e interni, i secondi ben piantati sul suolo, avanzano carri bestiame con sopra i cassoni animaleschi. Per filogenesi, miracolosamente fuori tempo, però ricca di antropologia fenogliana, la poesia di Per distratta sottrazione addita la realtà della carne che va nel vuoto, con tutta la fine del ’900 messa lì come fosse semplice addentrarsi in questa investitura. Non lo è, l’autrice lo sa, e zappando via ogni ostruzione delle misere facoltà attuali (la spianatura infame delle poetiche), non ci pensa due volte a decretare, ben dentro la struttura del verso, un’epica fin viscerale, domestica e altresì pubblica, un’epica che non si conforma alla fine degli scrittori, quelli che mettevano in chiaro ostilità verso i poteri biblici o riscaldati come brodo politico. Fenoglio, Vittorini qui non sono francobolli commemorativi ma incagliamenti che mirano a far fuori lo sporco corrente. Fuor di caserme e casini di realismo contemporaneo, che va pure bene quando s’intravvede uno straccio di prospettiva, Fosca Massucco denuncia, già nella prima fondante poesia del libro (“Non c’è differenza con il carro bestiame”), il disallineamento dei meccanismi della bilancia, il conseguente suo naufragio venendo meno l’equilibrio strutturale. Non indica, attribuendosi potere o misteri indistinti tali da alzare la voce, ma esegue tagli, passi, stacchi improvvisi, come solo la cinepresa unita al magnetofono sapevano fare in ben diversi tempi. Scrive, e non lo istruisce, che la luce, lux, sta sopra la terra, e gli esseri soprastanti muoiono. Come in un libro di lettura diventa facile capire in che modo lux serva a mostrare l’evento-morte. Nasce qui una prospettiva del verso che non è cupezza, né tattica il cui scopo sia far finta di nulla, anzi si avverte un piazzamento stabile contro la famosa nebbia “iniqua”, stabile nei territori abitati dalla poetessa, lei profonda come un tacco nel fango, o i cespi di rose a capo dei filari d’uva. Ma è sottraendo silenzio al silenzio che si odono i suoni, e tutti i crini dello spazio creato dai versi di Per distratta sottrazione.
Con questo incipit Elio Grasso introduce Per distratta sottrazione di Fosca Massucco (Raffaelli 2015). Non conosco personalmente l’autrice ma se dovessi parlare di lei, basandomi esclusivamente sui suoi versi, direi che è una persona straordinariamente capace del concetto della misura. Che non è controllo, anche se ha in sé intrinseco il controllo. La misura di Fosca Massucco è la capacità di computare il mondo, letteralmente di contarne gli elementi trovando quegli assenti che non sono mai realmente assenti, solo non immediatamente percepibili. Come dall’orma rimasta su un letto si può intuire la presenza umana, pur assente, appunto per sottrazione. Questo è un libro che a me pare abbia la pulita perfezione di uno specchio rotto, dove tutto viene restituito ma con spaccature perfettamente regolari, contenute nello spazio della rottura che è anche area di riflessione dell’immagine.
Il dolore è silenzio del tono puro / per distratta sottrazione. Tale definizione in versi viene data quasi subito nello svolgersi del libro e già in sé dice il bisogno di chiarezza dell’autrice. Nella misura che lei fa del mondo non emergono zone d’ombre, aree fumose, ma bene o male tutto emerge chiaro nella sua complessità. Privo di quello sviante coinvolgimento emotivo che non fa vedere bene. Ancora pensi all’universo capovolto, / dove traspare solo vuoto tra i cipressi / e la cinta delle mura? Il nulla / è immagine di sé e il vuoto / non è vuoto, vacilla in solitudine, che poi si conclude con anche nelle bare il vuoto / è più denso delle ossa. Una poesia quasi per definizioni, ma leggere, mai eccessivamente ingombranti.
Vi è una certezza di fondo, Riconsegno il senso alle cose – / autentica percezione di forma. / La mia ricerca è sempre controluce, / il rospo nella luna, che sa con certo pregio equilibrare la propria presenza privata non obbligando il lettore a confrontarsi con lei, ma anzi coi personaggi che lei racconta. Al mattino stemperarono i monti / e c’eri tu, repentina / come il miracolo di qualcun altro. / Si spuntarono le cime, / disfatti gli orridi e le gole, / tacquero i colori dei fiori. / La densità seccò cruda / come l’infiorescenza che scopre il frutto / in una stagione maldestra. / “Dèstati Deborah e intona un canto. Fino ad arrivare alle condense della terra rivoltata nel loro elencarsi (molto introspettivo) di oggetti che sono componenti del mondo: Occorrono il mulinello il trapano e la canna, / poi una seggiolina, / il silenzio scricchiolante, ghiaccio / che si fora, trucioli di neve – / l’occhio ai guizzi di dicembre.
Ora che ogni voce tace, / quale rifugio darò alle mie parole?. Il silenzio è sicuramente una delle componenti privilegiate di Per distratta sottrazione. Un silenzio che si declina man mano in è inutile, perfetta epifania / quel che solo posso dire, quanto in io che posso fuggire ancora / i rovi e la rabbia, fingermi senza / l’attenzione – la precisione / lasciata a dio, oppure in verso da cormorano del treno / che torna e cambia la stagione. Ma è quella precisione lasciata a dio che a un certo punto compare con l’evidentemente importantissima d minuscola (importantissima per un’autrice che, a conclusione dell’opera, impiega due pagine di note per spiegare riferimenti precisi e colti quali il mese mercedonio, il Locus dicitur praedialis, il giusto quale oggetto metallico che serve per riportare una bilancia a due bracci nel suo equilibrio) che più di tutto evidenzia la necessità di una precisione che in effetti è. È un bisogno di misurazione (la precisione è misurabile) che si scontra col dubbio che non esista tale precisione, senza disperarla, anzi invocandone la necessità (tutta umana, e forse anche per questo quel dio in minuscolo) in quanto rifugio.
Una precisione, una fotografia che renda chiaro lo sguardo (non a caso una delle sezioni si intitola Il dagherrotipo), per un libro che usa una forma molto chiusa, misurata anch’essa, dove ogni elemento nella sua musicalità ha un posto univoco (si legga il bellissimo Rincasa il ragno ballerino – / atto incosciente, / si rassegna alla gloria pervicace) e preciso. Una perfezione formale che ammette anche l’errore, come riflesso della realtà, tanto che se dovessi per concludere definire con due parole questo bel libro di Fosca Massucco citerei nuovamente le parole di Elio Grasso in prefazione ma non nella sua forma corretta, bensì con un piccolo errore, una svista, che a una prima veloce lettura mi è rimasta. Dove infatti si legge La bestia. L’uomo. Ma è un attimo, subito dopo inizia a camminare devo ammettere avevo inteso l’uomo è un attimo. Un attimo che, a conclusione della lettura, nel suo preciso essere un errore, a me pare particolarmente emblematico e onnicomprensivo.
È vera poesia bucolica, questa di Massucco. Si inserisce con composta naturalezza in una tradizione illustre, che parte ovviamente da Virgilio, tocca Pascoli (gran traduttor di Virgilio, oltre che bucolico di suo), arriva, come sensibilità, dalle parti della Pieve di Soligo di Zanzotto, mette gli a-capo a Fenoglio (è Elio Grasso, che firma la densa prefazione, ad accostare colline a colline, Langhe a Astigiano). Intendiamoci sul termine “bucolico”: non vuole rimandare a bozzettismo, a localismi di maniera, a arcadie provinciali. Piuttosto indica una poesia che insiste con sguardo acutissimo sugli oggetti, sulle creature della natura, anche quelle più nascoste o neglette, sulle tracce lasciate dal lavoro dell’uomo, sul paesaggio lavorato ostinatamente, anche, se vogliamo, su quel che di tecnologico che ha cambiato la vita delle generazioni dei lavoratori della terra e degli abitanti delle campagne. E forse, a questo punto, potremmo usare più appropriatamente il termine “georgico”.
Non a caso Grasso definisce subito il mondo poetico dell’autrice, il suo quadrilatero di riferimento, come “metropoli boschiva, zeppa di sguardo e di passi privi di retorica”. Si percepisce in effetti una sorta di pudore, nobile, che la Massucco esercita nel lavorare con le parole attorno alle cose che le sono care. Nei suoi versi l’attenzione per i segni della natura e dell’uomo non porta a toni altisonanti, a un’epica della campagna, a un’eloquenza muscolare (il rischio c’è sempre): piuttosto si sottrae, ci si ritrae, ci si finge distratti, si sbircia controluce quel mondo fitto di cose. “Bisogna avere grande prudenza / è tutto un universo di avvisi.” Si ricorre a quella mezza ironia che sorride di tutto, anche di se stessa. Si diventa reticenti, se proprio occorre.
Quei segni di cui la natura si gonfia in disordine, la poesia di Fosca Massucco li distilla in versi che sono un modello di sintesi (“Il disordine composto della piana / nel mese mercedonio, i campi gonfi / d’acqua – un giurassico in ritardo – / la perfezione vibrante del vapore”). La sua ansia di precisione lessicale tende a giocare con le antitesi e gli ossimori (“Il baccano della quiete di collina”, “una casa brulicante di silenzio”), talvolta si spinge verso singolari accostamenti, verso nomenclature insolite – ma ecco che le Note alla fine del volume ricollocano ogni analogia nel suo contesto, definiscono i termini (per esempio “mercedonio”).
Anche le scelte metriche si sintonizzano con questo bisogno di esattezza: oscillano tra le cadenze illustri della poesia italiana, tra endecasillabi e settenari, che ora dilatano ora restringono conservandone sempre una reminiscenza. Diciamo che i versi della tradizione sembrano funzionare come poli di attrazione a cui tendono le cadenze personali di Fosca.
Si sente che Fosca Massucco ama questo paesaggio delimitato e imprevedibile che è l’Astigiano, che non si stanca di percorrerlo con lo sguardo, di toccarlo, di camminarci, di viverci, di interrogarlo, di trovarvi un riflesso di qualcos’altro (di sé). A seconda di come lo guardi, della prospettiva in cui ti poni, un angolo familiare diventa nuovo, rileva nuovi dettagli. Amica dell’infittirsi delle cose, la poesia di Fosca Massucco è attratta anche – leopardianamente – dal suo contrario, dal nulla, dalla “compiutezza ineluttabile / del vuoto”: “Ancora pensi all’universo capovolto, / dove traspare solo vuoto tra i cipressi / e la cinta delle mura? Il nulla / è immagine di sé e il vuoto / non è vuoto, vacilla in solitudine.” La sua personale versione dell’Infinito leopardiano, insieme ironica e sentita, è “Davanti si porge l’eterno / in tutta la sua vacuità, / altèra gramigna / di massicciata.” Segni e silenzi: davvero Fosca Massucco si accosta al mondo come farebbe un musicista, come un interprete (schivo, però, lontano da ogni posa da virtuoso) a una partitura ancora carica di segreti.
Chiedo a Fosca se si ritrova in quest’immagine.
«Fino ai trent’anni» mi risponde «sono stata una cittadina impenitente poi il salto qui, isolata dal mondo il più possibile, mi ha catapultato nella realtà cruda. E questa vita nuova – o restituita – è fatta di drammi e tragedie quotidiani (animali morti, sbranati, frane, crolli, raccolti perduti, ghiaccio impietoso e terre argillose riarse), di banalissimi miracoli (il calicanto fiorito sopra un metro di neve, i cerbiatti e le volpi che passano in giardino con noncuranza). Ebbene, in questo universo perfetto l’intrusa sono io e mi ritrovo quasi sempre sul confine dell’osservabile, nel tentativo di trovare un equilibrio tra il rispetto che devo a questo mondo così crudele e l’innamoramento feroce per i suoi miracoli. Questo mio atteggiamento in qualche modo credo ricordi il momento, altrettanto carico di mistero e attenzione, in cui un musicista si accosta a una nuova partitura. Con la fondamentale differenza che un musicista arriva a dominare la partitura, mentre io non metto minimamente in conto di trovarmi un giorno regolatrice del mio mondo.»
Insisto su questo punto con Fosca Massucco, che è laureata in Fisica e specializzata in Acustica e anche sound engineer: quale spazio ha la musica nella tua poesia? Più precisamente, e se vuoi tecnicamente: come la tua sensibilità ai suoni (non solo la musica, ma anche i suoni della natura, della vita degli uomini e degli animali) si traduce nei versi? Di quale “musica” si nutrono i tuoi versi?
«Da più di quindici anni» precisa Fosca «mi occupo esclusivamente di rumore e di suoni; nei primi anni ho studiato i differenti tipi di disturbo e di silenzio, necessari per l’analisi acustica ambientale: ho imparato, insomma, ad ascoltare a lungo e considerare come massimamente significativo quello che gli altri trascurano o sopportano con fatica. Lo stesso approccio ce l’ho con la musica in sala di registrazione: il mio scopo non è mai quello di abbellire i suoni degli strumenti, piuttosto di eliminare il brutto che li circonda, lasciandoli più nudi possibile. Per rispondere alla tua domanda, i miei versi usano lo stesso metodo logico: tento di lavorare soprattutto sull’eliminazione del disturbo che si crea se il suono del verso – e dell’idea – non è perfettamente ridotto al massimo risultato. Di conseguenza i versi tendono a riprodurre le mie idee dei suoni – della natura o dell’uomo – ripulite dal residuo del reale.»
Fosca Massucco – ormai si è capito – oltre a scrivere versi sviluppa progetti di musica jazz e poesia in uno studio di registrazione, il (52 + 1) Studio, gestito con Enrico Fazio, compositore e contrabbassista. Le chiedo se può parlarci delle attività che si svolgono in questo suo laboratorio poetico-musicale.
Mi spiega lei: «Avere uno studio di registrazione in cui rifugiarsi ogni volta che se ne aveva bisogno è stato uno degli obiettivi di Enrico fin da quando acquistò il nostro casale ormai più di vent’anni fa. Quando poi io lo raggiunsi lì, iniziammo un lunghissimo progetto di trattamento acustico della sala di registrazione (che in realtà erano le stalle del casale), insieme ad un progetto “visivo” di confort emotivo: chi suona con noi deve vivere bene questa esperienza sotto ogni aspetto, dall’ospitalità, al rapporto umano, al risultato musicale ovviamente. Così, grazie ai contatti di Enrico e al suo lavoro da compositore, è iniziato un via vai di musicisti d’alto livello che vengono qui, si vivono le colline e suonano la loro musica o la nostra (se è una collaborazione per un disco di Enrico). Insieme allo studio ora gestiamo l’etichetta CMC Records, che in realtà è nata alla fine degli anni ’70, ha un catalogo di oltre 50 titoli e gestisce lavori in un’area che va dal jazz moderno, all’improvvisazione, alla classica contemporanea.
Parallelamente è nato il progetto poetico che stiamo sviluppano e portando in giro insieme a Enrico e al polistrumentista Gianpiero Malfatto: la sonorizzazione dei miei versi con una forte impronta di improvvisazione, che ha richiesto un considerevole impegno da parte di tutti e che si sta ampliando con l’uscita del libro nuovo. Lavorare in trio con due jazzisti ha costretto loro a confrontarsi con la parola scritta e mi ha insegnato a spiegare le mie poesie sotto il profilo musicale. Nello stesso modo, anche nel disco di Claudio Lodati in duo con Enrico, il brano Mirror Box è nato per ospitare i versi dell’omonima mia poesia, e la possibilità di essere io stessa a mixare il brano e intervenire sui suoni (oltre che a leggere i versi stessi) è stata un’occasione incredibile.»
Che cosa si progetti e si suoni nel ritrovo collinare di Fosca Massucco è ben esemplificato dal CD “Shibui”, firmato da Enrico Fazio con il gruppo Critical Mass (Leo Records, 2013). È jazz sontuoso e colorato, denso nella timbrica, nel tessuto armonico e nelle idee, che resta in equilibrio tra tradizione swingante e ricerca. L’ottetto mantiene un bello spessore orchestrale, una solidale compattezza d’impianto; allo stesso tempo il padrone di casa, Enrico Fazio al contrabbasso, garantisce spazio a tutti i componenti, trattati non come comprimari ma come interlocutori alla pari. Da compositore Fazio ama le pastosità scure, gli amalgami terragni e solidi, su cui voci singole (il violino di Luca Campioni, la tromba di Alberto Mandarini, il flauto di Gianpiero Malfatto) vocalizzano su un registro più acuto.
Concludo la mia conversazione con Fosca Massucco con una domanda che mi viene spesso, e che rivolgo volentieri a quegli artisti che lavorano sia con la scrittura sia con le note: c’è qualcosa che la parola scritta può “invidiare” alla musica (magari proprio al jazz, che ha una parte importante nelle attività del tuo laboratorio)? E qualcosa che la musica a sua volta può invidiare alla parola?
«Li vedo come due mondi gemelli impegnati a lavorare sulla logica, sui meccanismi e sulla creatività in uguale misura» mi risponde Fosca. «Possiedono la medesima tensione a una comunicazione speciale e diretta, parlano linguaggi con strutture e codici personali in modo identico. Al jazz, però, invidio l’emozione della scoperta ogni volta nuova dell’esecuzione, della coralità mescolata alla sensazione di assoluta libertà, controllata dall’arte. Viceversa, il pregio del lavoro poetico è che si svolge in solitudine, è autoconclusivo e necessita solo della pagina di un libro per entrare nella realtà.»
incessante negli anditi riverberanti dell’anima
come un crine ebbro di pece sulla corda.
Il dolore è silenzio del tono puro
per distratta sottrazione.
Alberto Mori – nota di lettura a “Per distratta sottrazione” su La dimora del Tempo sospeso – settembre 2015
Un momento esiste e lo si può dire: siamo ai piedi di una scala sonora ed è tutto vuoto intorno. Dentro e fuori.
“Sono le finestre del silenzio a creparsi” (P.21)
Vi è un paesaggio che assiste/assistendoci ed ha uno spazio di “sottrazione” nel quale la materia si evidenzia.Fosca Massucco ne coglie i vacilli,gli sfrigolii, la Mirror Box del corpo che ci riflette e ci contiene dove “L’immagine riflessa/ha più compassione di Dio” (p.25). Un simulacro “troppo umano” alla Nietzche continua anche il nostro non esserci.
Le Operazioni di creazione , come intitola la seconda sezione, sono invece procedure che individuano, riconsegnano la percezione attraverso le apparizioni della luce nella camera oscura. La sua prova impressa viene dalla ricerca mentre la natura continua.
Il Numero di Deborah avverte e mette a fuoco il dettaglio.Lo sforzo sublime della poesia che noma anche passando indetta davanti alle cose ed offre la conduzione dei sensi al senso anche quando si disfano e la musica resta sola.
Ora siamo dentro la terra e bisogna aprirsi fra “le condense della terra rivoltata” ed intanto il vuoto e la musica accompagnano.
Poi “I corvi indugiavano/celebrando l’immanenza del suono/poi tornavano nel fango” (P.49).Il destino perituro irreversibile ha questa pausa infinita di durata che la poetessa insegue fin addentro all’estinzione sonora degli scomparsi.Qui il suono deposto è semina per la memoria.
Si può dunque restare?
L’essere rimane senza rifugio e la poetessa è “derubata dai miei giorni da me sola” (P.54)
Per distratta sottrazione è unico sforzo d’attenzione protratta ma è così ben distillato nel mostrare i suoi mancamenti che ogni volta il lettore si riposiziona dall’innaturalità e si mette in ascolto. Questo range d’ascolto ha davvero un’amplitudo finissima da offrire poichè Fosca Massucco ammaestra le sue sparizioni per giungere ad aprire un transitorio esistenziale assoluto del suono bianco:”Risuonavano mortori e parti/nell’aria bianca pesando a tocchi/ e rintocchi i via vai del cielo” (P.49).
Siamo giunti ad uno “Still point of the turning wheel” Eliotiano, ma la poetessa non ha ascesa mistica da ritrovare nelle cose:ha un gran lavoro che la ritrova,quello di affrontare sè stessa e rifiorire.Anche nel gelo […] leggi il resto qui
Fabio Pusterla – sul libro “Per distratta sottrazione” – maggio 2015
“Ho letto oggi il suo libro arrivato pochi giorni fa. E vorrei dirle che mi è piaciuto e mi ha notevolmente colpito per l’intensità espressiva che lo sommuove, per il nitore del pensiero e infine, e soprattutto, per la justesse (lo dico in francese, perchè l’equivalente italiano mi convince meno) dell’espressione, della parola e del suono.”
Luca Benassi – nota critica a “L’occhio e il mirino” per ND – Arti, Musica e Cultura – ottobre 2014
In una celebre intervista per la RAI, Italo Calvino sosteneva come il genere umano, nella convinzione di poter governare e modificare la natura a suo piacimento, avesse assunto nei confronti di questa un atteggiamento quasi paternalistico. La natura era quella degli animali e delle piante a rischio d’estinzione, da proteggere, e allo stesso tempo, relegare nei parchi e nelle riserve; dell’ambiente si dimenticava la sua essenza, la sua onnipresente pervicacia, capace di stravolgere i pieni dell’essere umano e minacciarne l’esistenza (si pensi a certi eventi meteorologici di inaudita potenza). Calvino invitava a diffidare della natura e della sua ferocia, poiché nella bellezza e nella forza di un filo d’erba si nascondeva la prevaricazione di una specie sull’altra, la lotta per la sopravvivenza che portava all’annientamento. La poesia di Fosca Massucco sembra porsi in un rapporto di equidistanza rispetto a un ambiente del quale si coglie la ferocia e la meraviglia, dove l’unità di misura è sempre l’essere umano, capace dell’eccidio degli esseri che lo circondano e allo stesso tempo di essere scalzato dalla sorpresa di un pruno che nasce fra i binari. La natura non è né matrigna incurante delle vicende dei terrestri né cosmo da osservare nei suoi meccanismi fisici e matematici, ma un teatro naturale che ricorda la poesia di Giampiero Neri, all’interno del quale l’essere umano ricompre un ruolo importante, ma mai di protagonista assoluto. È anzi il suo ruolo di osservatore, di occhio-mirino, ad essere esaltato, laddove è l’osservazione stessa a creare le trame e l’ordito della natura, e a generare l’occasione della poesia. L’ecosistema è un luogo dal quel si è cacciati via, ma al quale si ritorna, alle sue ripe, ai suoi fossi, e nel quel non è la Storia e le sue vicende a segnare il tempo, bensì le metamorfosi incessanti e inarrestabili che trasformano la montagna in sabbia e questa nel castello che il bimbo costruisce sulla spiaggia. Massucco, che è laureata in fisica e specializzata in acustica, attenua la grana filosofica dei suoi testi, a volte vicina all’aforisma, con una versificazione alleggerita nelle strutture sintattiche e sempre musicale, vicina alla misura dell’endecasillabo con sonorità tonali ed immediate. Massucco è nata a Cuneo nel 1972 e lavora come Tecnico del Suono in sala di registrazione. Ha pubblicato la raccolta poetica “L’occhio e il mirino”, edita per L’Arcolaio di Gianfranco Fabbri (Forlì) a marzo del 2013, prefata da Dante Maffìa. È ancora inedita la silloge “Per distratta sottrazione”. [read more]
Manuel Cohen per «Punto. Almanacco della poesia italiana», anno 4, n. 4 aprile 2014 – recensione al libro “L’occhio e il mirino”
“Fosca Massucco: la mira dell’occhio”
L’esordio in volume di Fosca Massucco (Cuneo 1972), avviene in età matura, dopo un discreto apprendistato certificato da alcune pubblicazioni e premi (‘Anna Osti’ e ‘Città di Colonna La Tridacna’). A questi fattori estrinseci, oltre che ad un paziente lavoro sulla scrittura, è da attribuire il pregevole risultato de’ L’occhio e il mirino: un’opera prima che ci presenta una voce sicura nel passo, personale nelle movenze: parafrasando l’enunciato programmatico del testo e portandolo alle sue estreme conseguenze, si potrebbe riconoscere che il bersaglio o obiettivo sia stato raggiunto dall’occhio e con il mirino. Ma sarà utile per il lettore riportare un passo dalla prefazione di Dante Maffia: «Si avverte subito che la Massucco ha alle spalle molte esperienze che però ha diluite ricavandone impressioni, giudizi, sensazioni, percezioni che adesso la aiutano a saper guardare il mondo e a saperne leggere le coordinate. In ognuno di questi componimenti si avverte una saggezza che sembra provenire da terre lontane, dall’oriente, ed è per questo che la scansione dei versi ha risonanze di sinfonie. Ecco, musica e arti figurative entrano ed escono dal laboratorio della Massucco e fanno da contraltare con i suoi pensieri. È come se lei avesse fatto incetta di sensazioni e ora volesse riordinarle attraverso lo sguardo mirando al centro. E bisogna dire che ci riesce e riesce a creare anche una circolarità espressiva senza vere e proprie cesure. Le poesie non hanno titoli, sembrano essere il frutto di un progetto poematico che si muove roteando e non lasciando però nulla al caso». Il libro, perché di libro e non di semplice raccolta si tratta, è suddiviso in tre parti, tre scansioni che già dalla titolazione accostano l’autrice ad una dimensione classica: alla maniera degli antichi, il libro racchiude in sé tre libri autonomi e interrelati, tre discorsi, tre dissertazioni in versi, secondo modalità proprie della poesia: di dio, dell’armonia, delle cose. Tre trattati naturalistico-filosofici. La risonanza classica trova conferma inoltre nella lingua: chiara, luminosa, comunicativa; nella sintassi: tra costrutti brevi e ampi periodi mai involuti, con ricorso alla paratassi; nell’argomentare: una poesia che si fa carico di un ragionamento logico, anche nella illogicità della materia, tende a coinvolgere chi legge, tessendo un ordito di pensiero; infine nel particolare approccio alle cose di natura: la natura è continuamente sollecitata dall’umanesimo sensibile di chi la vive, e attraverso le sue manifestazioni si configura quasi a emblema, o spia, del sentire umano, del suo destino. E nelle cose di natura, Massucco rivela quella particolare tensione, lirica e musicale, speculativa e ontologica, che porta a confluire la Classicità (di pensiero, di sguardo, di lingua) con il secondo termine a quo: la Modernità, infine con l’urgenza, tutta contemporanea eppure così a-storica, del quotidiano. Per meglio chiarire, a vantaggio del lettore, si porta a esempio il testo di pagina 34: Ci sono istanti di marzo che inducono all’attesa. Qui si parte da una perfezione, quasi asettica, nella icasticità della visione, che nell’avverbio del secondo verso sottende a una riflessione tragica, quando non nichilista: dalla immobilità colma di domande e di aspettativa: «Ci sono istanti di marzo che inducono all’attesa / e mi vedono scrivere, china, inutilmente». Immobilità, stasi, rafforzata da una tipica doppia immagine classica o ieratica: «Seduta, guardo fuori dai vetri / il giardino immobile che chiama», dove l’insistenza sul dato di staticità (nei lemmi ‘seduta’, ‘immobile’) riguarda essere umano e natura circostante: natura naturans e natura naturata. Il discorso è sempre in prima persona, l’io lirico (contrariamente a tanta poesia in atto) non disdegna di dirsi e di nominarsi in prima persona. Ma partono sottili incrinature, dubbi attivi, propri di chi rivela attenzione e presenza, lettura e cultura di classici (Lucrezio, i lirici Greci) e di moderni (Baudelaire, Emily Dickinson, Leopardi, Pascoli, Eliot): «chi non dimentica […], chi sfugge / al fiato mozzo guardando il dito che indica la rondine?». Ma il quotidiano insiste, bussa alle porte, e non si può non aprire, non gettare l’occhio e il mirino al presente: «Io mi incanto anche nel niente, non mi serve un motivo / per volare – poi atterro veloce. Ci sono panni e pannolini, / minestre e cure che mi tengono occupata, / non è facile il mestiere del poeta al giorno d’oggi.». Il libro si muove tra ricerca del sublime e percezione di una fisica perfetta, tra immobilità e mutamento, metamorfosi del cosmo e delle creature, in un linguaggio visivo: «Il cielo plumbeo di aprile -/ la scena ripetuta all’infinito», e al contempo, carico di visione, visionario: «una lama ingiallisce le nuvole, / conto i danni nel frutteto». Musicalissima artigiana di parole, Fosca Massucco cura il proprio orto giapponese consapevole dell’armonia degli elementi, dei piccoli solchi, e della repentina possibilità di perdita, dell’assenza di ogni riparo.
da “La Dimora del Tempo Sospeso” :: Repertorio Delle Voci – Nuova Serie N.8 (XXXV)
http://rebstein.wordpress.com/2014/08/20/fosca-massucco-la-mira-dellocchio/#comments
Non è il caso di Massucco, la cui lingua arriva alle questioni squisitamente “terrestri” attraverso una inquietudine conoscitiva ben impostata e intensa (“Oggi sono verticale.| Gravida per induzione…”).
Il suo è un orizzonte posto su dimensioni aspramente fenogliane, dove il mito delle terre e degli uomini rasenta le porte di casa, si infila nella buca delle lettere (“Quando fui solo un pensiero / c’eran di mezzo lenzuola al vento”). Terreni verticali, muri storti, luce violenta dopo la neve, passi dove il gelo del terreno invernale non spaventa ma arricchisce il verso di slanci civili.
Ogni poesia porta all’equilibrio della successiva, diventa scaffale per i libri della vita, e poi stanza, e infine casa, dove sta un confine amato. In questo asilo geografico e mentale Massucco riesce a rifondare le prove del quotidiano con ostinata ricerca.
Giorgio Bàrberi Squarotti (Presidente di Giuria – Premio Nazionale “Beppe Manfredi – Opera prima” – commento a “L’occhio e il mirino”)
Un libro d’esordio che parla di Dio, dell’armonia , degli oggetti con precisione lessicale rara, essenziale, scavata a fondo nella roccia per cercare la purezza. Una poesia che non fa facile filosofia, ma cerca il senso concreto delle cose, anche servendosi della sorpresa, del contrasto del salto logico. Una poesia matura.
Narda Fattori su NeoBar di Abele Longo – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
Quando ho ricevuto il libro ho pensato che avesse un titolo ridondante, poi subito riflettendo ho colto la differenza: l’occhio è la visione, una vista ampia, ricca di elementi particolari e perfino spuri, il mirino , invece, centra il particolare, affina la vista su un solo oggetto; un po’ come succede nella vita dove la ressa degli eventi ci fa perdere di mira l’elemento che distingue, che rende l’unicità , l’irripetibilità, un sapore, un solo colore…
Fosca credo che proprio questa unicità abbia cercato e cerchi, ed è un unicum e un solum minuscolo, poco appariscente, che una visione ampia non coglierebbe , solo il mirino può metterlo a fuoco, centrarlo, col dubbio di esserci riuscito: “Un tintinnio di cimbali- / a l’entrada del temps clar / ciangottano le nevi sciolte/ preghiere brevi, la lievità di dio/ in un giardino di semplici”
Fosca è forse alla ricerca della divinità?
Se così fosse il suo dio indosserebbe la maiuscola, invece è una divinità minuscola di piccole perfezioni, di “ciangottii”, appunto, di armonie, sempre presente e quasi inafferrabile . E’ colui che insuffla la vita e , necessariamente non è il Dio dei cristiani, potrebbe essere Ganesh o un qualunque altra divinità pacifica , che poco chiede e forse di meno si accontenta e/o si manifesta.
“di dio” è il titolo di una delle tre sezioni del libro, e torno ad affermare che non c è nessuna ricerca teologica, semmai c’è la presa di coscienza dello stare singolo davanti ad una divinità che qui non ha precetti ma solo manifestazioni e nessuna sapienza saprà mai cogliere l’istanza che pone.
Malgrado cumuli di conoscenza , l’uomo resta un leggio vuoto.
La morte che ogni tanto si affaccia nei versi è definita come l’ascesa verso il silenzio di dio.
E’ una definizione che ha lasciata perplessa, come se il silenzio totale fosse il vero stato di beatitudine contrapposto al bailamme terrestre di suoni stridenti, di pianti,…
La seconda sezione è titolata, non credo a caso: “dell’armonia”. Se le poesie dedicate a dio chiamano cose semplici , anche l’armonia non può che essere costituita da minuzie quotidiane, di gesti di pace, di nutrimento che si dispongono a trionfo dell’anima:” per chi è uso al silenzio/ anche una sola strofa/ è un volo all’improvviso.” Credo che meglio non si potesse dire sulla potenza del silenzio e della sua rottura con l’introiezione di altro senso. Ancora più di frequente che nella prima pagina, gli elementi semplici e spontanei della natura sono visti come indizi del dio, dell’armonia, dell’uomo immerso nella natura che se la lascia sfuggire in gran parte. Ci sono mesi e venti, sole e tepori, cieli plumbei , l’immobilità agostana,….., c’è un tutto che si lascia sfiorare perché la vita ha altre incombenze e volare è lusso d’uccelli. E’ la sezione nella quale vediamo la poetessa come donna, come madre, come lavoratrice, insoddisfatta fra il dovere e il desiderio, non diversamente da noi.
L’ultima breve sezione è più riflessiva, forse anche più amara: “ ed io mi ingegno/ a contare stelle e nubi fugaci,/ distraendo il desiderio/ coi sonagli dell’usuale”.
La presa di coscienza quasi gridata della propria unicità quasi ci stupisce e contrasta con la missione laica di attraversare il mondo senza neppure sollevarne la polvere. Fosca è donna e poeta, nulla di speciale, solamente la sincerità si fa spudoratezza quasi fosse ad una dimensione invece delle solite tre che s’azzuffano e le altre che maggiormente invisibili si contendono le ragioni all’interno del singolo.
CONTINUA A LEGGERE QUI
Alberto Mori su La Dimora del Tempo Sospeso – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
Qualcosa di imperfetto che giunge e raggiunge mentre il tempo si restringe e bisogna farsi trovare pronti… Dio ha inviato il segno. Due corvi.
Alla fine dell’insonnia è necessaria una trasformazione.
Una trasfigurazione.
Nella prima sezione intitolata “di dio” del libro L’Occhio E Il Mirino di Fosca Massucco si avverte una premizione sotterranea. Il desiderio della preghiera di uno sguardo diverso alle cose mentre la poetessa si dispone anche all’inatteso, perché ogni certezza sembra esaurita ed ora: “Ci sono luoghi in cui / è Dio pellegrino a trovare me” (P.10).
La natura si agita e viene agìta: sente l’angustia di chi la pone in versi anche quando “La rosa rampicante, ad esempio, non rispose più / inchiodata dal sole, fiorita di pidocchi;” (P.25).
In questo “jardin de la souffrance” nasce la rivolta della poetessa.
Ella si pianta con il corpo nella terra per aprirsi profonda. Non perdersi e disperdersi.
Così nella seconda parte (“dell’armonia”), la poetessa colloquia fra sé nella ripetizione dei gesti quotidiani, immobile di fronte ad una natura che continua ad essere indifferente.
Il paesaggio esistenziale non permette più “il tempo di guardarmi da fuori”, ma intanto cresce un movimento che sospinge lo spazio, inscritto in un tempo che via via si rastrema e si incarna di luce sorta polita, come accade in un verso d’apertura davvero mirabile che va considerato da solo sia per la sua costruzione allitterata fonosimbolica che per il suo notevole esito di senso plastico plasmato all’invisibile:
“Statue di albe senza dimensioni”. (P.43)
Un nuovo tempo si rende disponibile. Ora è il gipeto che si alza in volo poiché: “Nulla è sublime più che attraversare il mondo / lasciandolo immutato.” (P.44) proprio come gli uccelli che lo trascorrono nei voli e portano lontano anche quota e precisione dei nostri sguardi.
Nella parte finale della plaquette la poetessa si autoritrae e sembra ora possedersi compostamente. Trova il sostegno “delle cose”. La concretezza e la sua concrezione trovano un’altra natura sempre a lei corrisposta: “Voglio fare come il bosso in giardino (…) gettare radici e protendermi tenace negli anni” (P.50) e se ritorna l’attesa, è quella del parto, del deporre la propria consapevolezza attraverso questa auto restituzione che avviene nell’anima della poetessa per frequenze oscillanti del sentire che comincia ad aprire la sensualità amorosa.
“L’Occhio E Il Mirino” è una raccolta di versi che svolge in acutezza di sguardi ed attenzioni la natura dei versi per trovare luce di individuazione condivisibile, sia da un mondo silenzioso di rivelazioni che da quello contemporaneo, il quale scandisce i suoi inesorabili protocolli spesso fatti di nulla e la poesia fra queste polarità accolte con mente e corpo in ascolto conosce e trova da sola la sua strada.
CONTINUA A LEGGERE QUI
Antonino Caponnetto su Poesiaperta – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
C’è nei versi di Fosca Massucco qualcosa di trattenuto, di riservato, di intimo e profondamente misterioso. Si tratta tuttavia di qualcosa di vitale e determinante, il cui ampio, costante respiro si avverte con forza attraverso i grandi spazi bianchi o i misterici luoghi del non detto. Le mie impressioni peraltro sembrano suggerirmi che in questa poesia non esiste indicibile che possa resistere e perdurare come tale, senza trasformarsi in qualche modo in altro da sé, così da intrecciarsi entro il variegato tessuto dei versi, per esservi quantomeno percepito se non addirittura abitarvi col rango chiaro di un significante. Con questo voglio affermare che il far poesia di Fosca dispone di mezzi e strumenti di ricerca, d’indagine e di scavo tali, e usati con tale destrezza e maestria, da scardinare, quando è necessario, la tradizione consolidata. Di farlo ogni qualvolta quest’ultima si tramuti in pigra e abitudinaria lingua, i cui canoni vorrebbero apparire immutabili e insofferenti ad ogni inevitabile sviluppo, o al contrario (come succede ormai sempre più spesso) mostrarsi disponibili a inglobare in sé ogni e qualunque “contenuto” oggi si voglia far passare per poesia.
Da questo libro, dalla poesia che in esso si esprime, sono stato fortemente attratto fin dalla primissima rapida lettura. Già mi sorprendeva e stupiva il linguaggio poetico usato, la struttura e l’architettura complessiva dei versi, quella sorta di responsabile coraggio che notavo nella scelta degli eserghi e, sopra ogni cosa, la chiarezza e la luce che permea ogni singolo verso, ogni poesia, ogni sezione del libro. E infine il libro stesso. Di questa chiarezza e di questa luce dico qui, ripetendomi per la millesima volta, che entrambe sono figlie e madri di una semplicità pazientemente e duramente conquistata. Sì, perché la semplicità è una grande conquista, ma è anche la conquista dei grandi. Essa richiede coraggio, costanza, caparbietà e amore per la propria vita e per la propria arte. E io credo che sia stato tutto questo a fare di Fosca Massucco la poetessa che è. A permetterci di intravedere un futuro assai significativo e importante per lei e per la sua ars poetica. Ci auguriamo dunque di poter leggere presto quello che in un certo senso le è già destinato scrivere.
CONTINUA A LEGGERE QUI
Luca Pasello su Poetarum Silva – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
“Heri dicebamus. A qualche mese dal piazzamento al premio Anna Osti e dopo svariati commenti sulla poesia di Fosca Massucco, è forse possibile rintracciarne il profilo con qualche certezza in più (e un libro a disposizione).
Il catalogo critico sin qui accumulato raccoglie poche ma ferme acquisizioni: su tutto la levità, una leggerezza come dote ingenita, il coraggio della facilità; quindi misura, stilizzazione e un’idea del mondo basculante tra scetticismo blasé, saggezze orientali e sapere razionale. Da ultimo (not least), ottima per equilibrio, la coesistenza di disciplina e immaginazione, “di matrice scientifico/tecnica ma […] inscritte in un registro apertamente lirico”. [1]
Quella (felice) facilità, soprattutto, e l’occasionalità del fatto poetico (un “progetto”/blog come officina, ogni nuovo brano come corsa sul posto e momento concluso) celavano alla vista un paio di nodi cruciali e un’idea di sviluppo che la forma-libro quasi esibisce.
Ripartiamo, dunque, e per prassi eterodossa ci piace farlo da espressioni rubate a uno scambio confidenziale, da impiegarsi quali reagenti a crudo: “Son di Cuneo, figliolo, ho sangue metà alpino e metà partigiano, non mi sta dietro manco Dio… per espiare corro coi cani fino all’infarto e guardo le lepri e i tassi… qui le faine cattive staccano le teste ai gatti con giudizio e la mattina si fa la conta… la Langa è cruda è stupenda, d’estate mignotta, ma senza dolcetto e barbera è infame… quando canta, l’upupa rompe e le tirerei una palata”. C’è roba notevole: “per espiare” cosa? e poi le Langhe crudeli (non memoria, men che meno letteraria: questa è natura e ci torneremo) e la liquidazione dell’upupa a babbo Montale morto, via da una certa lirica.
Per ora, l’idea di espiazione è un buon punto archimedico. Assunto che una qualsiasi religiosità a sfondo morale è quanto di più distante dal mondo di Massucco, non si espia che il dato di natura anteriore alla volontà – in questo senso, si espiano la Langa, l’amore per essa o il suo tradimento.
E così affiorano tragitti che non t’aspettavi.
Torniamo dunque al libro e vediamone la partizione: di dio – dell’armonia – delle cose (anche leggibili, ma per trompe-l’oeil che crediamo fuorvianti, come sintagma unico: di dio come armonia delle cose[2]… del dio dell’armonia delle cose…). Ecco la sorpresa: se la terza stazione è data dalle “cose”, il libro va verso l’ancoraggio, arriva alla massa inerziale come dimensione di solidità selvaggia (la natura, i luoghi della vita), ovvero (che è il medesimo in altro codice) tradisce ansia di radicamento e permanenza, rusticità salute e concretezza dei giorni[3]. Ma se è colpa viversi in quanto ingombro, se siamo accidente che perturba e Nulla è sublime più che attraversare il mondo / lasciandolo immutato, siamo già alla quaestio definitiva: cosa ci faccia, in tanta robustezza, quel fare spazio a vuoto e silenzi[4] delle prime due sezioni; cosa sia quel nulla come respiro del mondo, o la minuzia del dettaglio illuminante, come la fragola della parabola zen.
Se qui il buddhismo non è ghiribizzo da borghese in vacanza (non lo è), c’è un gran bel contrasto da risolvere.
Oppure no, scemi noi: la lirica è ricerca attorno all’io; ma perché questi non la recinga nella propria angustia c’è bisogno di mondo e al tempo stesso di de-cidervi l’inessenziale, ritagliando sentieri che ne allevino il peso. I sentieri di Massucco sono “semplici” modalità: lo è lo sguardo orientale, lo è pure la scienza e il titolo del libro li sovrappone identificandoli nel luogo poetico.
Così, capita di trovare l’inventore dell’atomo non in epigrafe ma dentro il testo (non distante dalla Cabina C al chilometro 1 + 105 e da un verso trobadorico occitano), essendo a lui commesso di trapassare il diaframma tra visione e modello fornendoci la chiave. E appunto: realtà (visione della) o modello, caso o necessità ovvero occhio o mirino[5] sono cimenti che stroncherebbero il filosofo più navigato. A meno di non essere poeti, ché in tal caso la risorsa (la “via”[6]) è lo nello stile.
Massucco non è buddhista, non è scientista, nemmeno gioca temeraria e svagata tra sensi, anima e pensiero[7]. Fosca Massucco è poetessa a suo modo oraziana. Lo è in versi come Deve trovarmi pronta l’armonia / delle cose – / un gatto, un falò, un inverno[8], o dove emergano la dimensione appartata e domestica, la tendenza al sermo, di tanto in tanto, o alla gnomé. Ma lo è anzitutto tecnicamente, per un felice gioco di iuncturae buone a risemantizzare parole e
mondo, in un’esperienza sapienziale ottenuta via tono e dettato. Si tratta insomma di auree e meticce medietà espressive che compongono, pacificandoli, Tibet/Langhe/poesia/scienza/sé/mondo.
Se il Modello – ciò che vedi dal mirino – si genera da uno stilismo della parola anteriore, persino, ad ogni portato semantico (operazione analoga è mutuare nomenclature scientifiche a uso poetico), allora l’ibridazione lessicale, nonché esercizio metaforico, diviene callida iunctura[9] per posatissime artes vivendi mentre l’acris iunctura[10], più parcamente presente, fa spazio alla scepsi ed è sana riserva di dubbio o modestia[11].
Solo così, quando il mirino inquadra l’oggetto, si tratti di illuminazioni per accensione d’immagini o delle più distese effusioni discorsive della terza sezione – solo così è plausibile che il baratro liberatorio della scoperta conduca sino al Giappone astigiano.
________________________________________________
[1] Luca Rizzatello, Commento in anteprima a L’occhio e il mirino, http://521poesie.com
[2] Deve trovarmi pronta l’armonia / delle cose – / un gatto, un falò, un inverno / o pressappoco – / prima che cambi idea.
[3] …ingollerò molliche di stabilità quotidiana…
[4] Un intero saggio andrebbe riservato al trattamento che, ne L’occhio e il mirino, il fisico acustico Fosca Massucco riserva ai suoni: cimbali… ciangottio di nevi sciolte come voce di un dio lieve; vento e ruggito di vespe; addirittura il tempo che ristà crocchiando / come legna estiva ad asciugare o che, con suono finissimo, rumoreggia / come di sabbia. E lamentava di recente, Fosca, una carenza di “legno e corda” nella presa del suono di una registrazione musicale – ancora materia e senso tattile per quanto di più aereo si dia tra i fenomeni.
[5] Così sale un arcobaleno in quota – / l’occhio è un mirino, a fissarlo non lo scorge – / inchiodato al cielo tra gola e vetta. E se capiti che la mira fallisca e che il poeta ammetta non salvai nessuno, un rimedio si trova: quando cercai un arcobaleno a forzare i tempi, / aprii l’acqua del giardino in controluce.
[6] …prego poco e male, ma quella è la via – il Ganesh, certamente, ma in poesia un Ganesh è dato stilistico efficace per dinamica testuale, oppositiva/combinatoria.
[7] Nulla di sbarazzino, dunque, nella sua levità, come credevamo in passato.
[8] Vides ut alta stet niue candidum / Soracte (…) Dissolue frigus ligna super foco / large reponens…
[9] …i fasci / di tempo allacciati a covone… quanti di gioia… Un miserevole frattale ricomposto, / vano quanto bruma bassa… Altrove siamo alla calligrafia, con qualche rischio connesso: fogli di vento… sonagli dell’usuale… il vento scrolla le vespe dell’alba… statue di albe…
[10] Un volantino che dona sorrisi in ascensore (…) col 50% di sconto
[11] Deve trovarmi pronta l’armonia / delle cose (…) prima che cambi idea… Non salvai nessuno… Io sola so / e non mi servirà a nulla.
Giacomo Cerrai su Imperfetta Ellisse – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
Il genio dell’uomo è foggiare
rotonde balle di fieno
immote in una laguna
d’erba disseccata.La perfezione di dio
è disporre sopra due corvi.
Giorgio Linguaglossa su POESIA 2.0 – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
Spesso leggendo tanta poesia contemporanea mi assilla il dubbio che un eccesso di armonia, un sovrappiù di lucidatura del pavimento, dell’argenteria e degli stivali di pelle non comporti anche il sospetto, in chi osserva dal di fuori, che dentro l’appartamento profumato e lindo con deodorante da supermarket non si nasconda, in qualche armadio, il cadavere messo sotto naftalina di qualcuno di famiglia. Insomma, se questo eccesso di deodorante non serva che a nascondere il puzzo ingombrante e intollerabile di un cadavere. E allora mi viene voglia di indagare oltre la cortina di nebbia del deodorante, al di là delle lucidature dell’argenteria per scoprire l’innominabile cadavere che si cela da qualche parte, nascosto in qualche latebra del soggiorno di casa. Allora, apro le finestre, voglio far entrare un po’ di aria fresca. Mi viene il sospetto che tutta quella modanatura, quella lucidatura non sia altro che Kitsch, ottimo, metallico, rassicurante Kitsch.
Fosca Massucco con questo suo libro di poesie d’esordio si comporta come un commissario che stia facendo un sopralluogo sul luogo di un delitto presunto, si muove come se fosse in presenza di un fumus criminis; mette i numeri sul luogo, misura le distanze tra il cadavere e le cose, riepiloga l’accadimento con lo sguardo, lo ricostruisce con gli occhi. Fa così anche la sua poesia, che definirei, crittografia dello sguardo, iconologia dell’occhio, logometria della visione binoculare, giacché la poesia si dipana sempre a seguito di un atto di visione passato attraverso il filtro di un sofisticato pensiero estetico. La Massucco si muove con circospezione, in sordina, in punta di piedi, in punta di penna. Certi giri frastici ricordano il nitore e la raffinata trasandatezza metrica della poesia di una Antonia Pozzi e di Anna Achmatova; c’è un elegante distacco dalle cose, un nitore degli oggetti posti a presidio della visione, una gentilezza dello sguardo che è il riconoscibile pegno della modestia, della misura delle cose che ci accompagnano. Poesia sofisticata e colloquiale, semplice e altera, elegante e misurata, prodotto di una voce, come dire, antica e modernissima, che ha la tristezza di un brindisi con la persona che non amiamo più e la gentilezza del commiato. La tristezza di un amore che si è disamorato e la gioia aurorale di un cielo azzurro. Poesia di un congedo in punta di piedi come di chi non voglia disturbare i contemporanei assorti e immersi nelle distrazioni del contemporaneo. LEGGI IL RESTO
Maria Grazia Di Biagio – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
C’è un assaggio di Nirvana, nella levità profonda del discorso poetico di Fosca Massucco; una rivelazione che non si impone ma guida il lettore con ampie scintille di luce verso la consapevolezza di una immanenza che rimanda al Tutto.
Leggendo “L’occhio e il mirino” il pensiero corre a Schopenhauer, al Velo di Maya che separa questo “universo angusto” dalla verità del Noumeno cui l’uomo tende a ricongiungersi e che deve arrivare a scoprire tramite un iter salvifico che passa per le vie dell’Arte giungendo all’Ascesi.
E qui l’arte si esprime nella finalmente ritrovata armonia tra forma e sostanza in un dettato luminoso e illuminante fondato nel giusto equilibrio fra “langue” e “parole”.
“Si può affermare che il discorso poetico abiti ancora il cuore del Moderno?” Quando, poco più di un anno fa, Giorgio Linguaglossa poneva questa questione, la Casa Editrice L’Arcolaio non aveva ancora pubblicato “L’occhio e il mirino” di Fosca Massucco. Oggi possiamo rispondere: sì, perché i poeti esistono. Sì, perché la poesia è un sentire che vuole essere detto, condiviso e compreso, è dentro il quotidiano del poeta:
“Io mi incanto anche nel niente, non mi serve un motivo
per volare – poi atterro veloce. Ci sono panni e pannolini,
minestre e cure che mi tengono occupata,
non è facile il mestiere del poeta al giorno d’oggi”
E non occorre nascondersi dietro cerebralismi falso-intellettuali quando è chiaro ciò che si ha da dire. Il verso è già nell’aria, non resta che accoglierlo e renderlo con un gesto istintivo, naturale.
A scrivere poesie siamo in tanti, ma i veri poeti sono pochi. È questa la vera questione, a mio avviso.
La crisi nella quale versa la poesia moderna è dovuta ad una eccedenza con conseguente eccesso di meri esercizi stilistici votati all’auto-compiacimento di chi non ha niente da dire e deve nascondere quel niente dietro un muro di lessemi deflorati.
Il poeta, quello vero, ci mostra l’infinito con un gesto semplice: apre “l’acqua del giardino in controluce” e fa l’arcobaleno.
Maria Grazia Insinga su Words Social Forum – nota al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
Quello che subito balza agli occhi leggendo queste poesie è la stilizzazione degli elementi di una mitologia quasi panteistica in funzione dell’elaborazione lirica. Un poetico “Mikrokosmos” bartokiano – argentino, agile, sapientemente infantile – caricato però di nuovi significati in un clima dickinsoniano.
Per un orecchio poco avveduto l’armonia di queste poesie é apparentemente tonale: il tono non é fumoso, il ragionamento non é contorto ma lineare nell’uso di un solo io lirico. Le tonalità utilizzate sono, però, più di una come nelle “Bagatelle” di Bartók. Poi, invece, la musica delle “Danze rumene” prende il sopravvento con le sue magnifiche scale modali. In effetti, il centro tonale è l’occhio: punto di riferimento indispensabile dell’osservazione le cui fasi – “Mattino”, “Pomeriggio”, “Sera”, “Senza notte” – rappresentano le linee melodiche concomitanti. Tutto torna! La musica in risonante anticipo sulle codificazioni del pensiero ha un senso: è proprio in India, infatti, che esiste forse il più complesso sistema modale del mondo; ed é proprio l’India la terra natale della mitologia sulla quale si erge questa delicata poetica.
Lung-ta imbizzarrite a simboleggiare l’anima, dalbergia (con essa si costruiscono anche strumenti musicali), rosari da cui distillare la Grazia separandola goccia a goccia grano a grano: di queste cose è scritta la Bibbia di Fosca Massucco, questa è la sua mitologia. E nel dio pellegrino c’è la ricerca e la gioia della condivisione intesa come viaggio della mente che dalla testa va al cuore (ci sono luoghi in cui è dio pellegrino a trovare me).
Tra eros e morte, immobilità e pellegrinaggio interiore, dimensione domestica e celeste si snoda, dunque, questa cosmogonia dove l’io è l’occhio che detta, estraneo alla storia, autoriferito. La grammatica colta si fonde con gli esiti di questa esplorazione che registra con precisione scientifica il punto in cui andrà inciso il carattere. La Grazia qui è precisione affilata come un coltello e serve a costruire per sottrazione lo spazio di un rifugio, di “una stanza tutta per sé” (V. Woolf). Non è la poesia ad essere vista come problematico distacco dalla vita ma è al contrario la vita che, sissì, deve rispettare questi spazi. I voli all’improvviso non hanno bisogno di aggettivi: il loro pregio sta, appunto, nello scavo. Il coriandolo del davanzale e i sonagli dell’usuale sono i segni di un ritorno intenzionato alla quotidianità.
Fosca Massucco gioca a fare Nusch consapevole che essere solo musa è riduttivo. O meglio, lei é Musa ma non di un poeta, di un musicista o di un artista tout court: é Musa della Bellezza! Esattamente come Nusch.
L’ironia di unduettrè, unduettrè, così come quel Natale che non arriva a convincere fanno da corollario al rifiuto delle convenzioni della vita. Ricorda molto la Dickinson ribelle che tenta di superare le finzioni dell’esistenza con un linguaggio nuovo. Ma qui la parola si ancora alla realtà nel suo essere scientifica mentre la fusione tra verso (che si ripiega su se stesso) e prosa, libera la versificazione dai confini della metrica. L’ispirazione splende maggiormente dove si affranca dalle lacerazioni quotidiane, dove è più lucida, dove osserva per elencare senza desiderio di modificare il reale perché c’è identità tra corpo e poesia, e trapassare il diaframma è la sua vocazione. Perché “l’uomo circondato da pensieri già fatti, la ragione degli alberi e delle pietre, la ragione della luna e dell’acqua, non ha altro intento che enumerare e contemplare” (J.-P. Sartre).
Diffido degli approcci di genere; la poesia non è uomo o donna, la poesia è stupore, l’essere umano è stupore. È innegabile, però, che esista un dialogo silenzioso interno alle donnepoeta italiane e straniere per via d’una sorta di naturale linguaggio metafisico femminile: un filo sotterraneo che unisce al di là dei confini ed é presente in questo libro. Ma non é forse un privilegio?
Ora attendo che a questa poetica segua la costruzione di una cosmogonia ancora più maestosa. E spero che nel suo cammino l’autrice continui a non salvare nessuno (sale l’arcobaleno in quota; Pomeriggio), a lasciare tutto com’è (Viver come drappo rosso non è facile) salvo forzare poi i tempi di un arcobaleno inteso come miracolo che scardina l’ordinario.
Questo è il primo luminoso passo di Fosca Massucco. Se davvero, come dice il matematico Benoit Mandelbrot, i frattali hanno corrispondenza con la struttura della mente umana, probabilmente il ‘frattale-Fosca’ deve essere molto simile a quello di un fiocco di neve. Qui in Inghilterra nevica e dopo la lettura di queste poesie giurerei d’aver sentito le nevi ciangottare…
Un tintinnio di cimbali –
a l’entrada del temps clar
ciangottano le nevi sciolte.
(dal Words Social Forum)
Luca Rizzatello [Prufrock SpA] – un commento in anteprima al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
Conferma e potenzia le impressioni che avevo avuto dalla lettura della raccolta con cui hai partecipato al Premio ‘Anna Osti’. L’opera è tonificata da due macrotensioni: la disciplina e l’immaginazione. E la buona novella é che questa disciplina e questa immaginazione sono di matrice scientifico/tecnica; ma essendo inscritte in un registro apertamente lirico, il risultato che ne viene è un sistema di codici molto ben integrati, che sulla carta apparirebbero destinati a confliggere o peggio a rimanere separati, se non armonizzati da una regia stilistica consapevole. La quale si manifesta innanzitutto nella levita’ di cui parlava Luca Pasello nel suo commento, e che in termini retorici é un cavallo di Troia per raggiungere un pubblico ampio di lettori, che, consapevolmente o inconsapevolmente, potranno beneficiarne. In riferimento alla forma del libro, il tutto si tiene in maniera coerente e consistente, e ora ti rassicura, ora ti mette alla prova, inducendoti a portare lo sguardo oltre la staccionata umanistica. Così la strategia compositiva si realizza nel ribilanciare continuamente i rapporti tra un istinto letterario creaturale piuttosto smaliziato (in altri termini, e ad esempio: Francesco d’Assisi in possesso del vocabolario pascoliano) e una riflessività analitica che ripulisce il discorso da quanto sarebbe accessorio o poco funzionale (e qui vorrei utilizzare la metafora del rasoio di Occam, se non fosse che anche William of Ockham, come Francesco, era un francescano; e per spiegarmi questa coincidenza il rasoio di Occam dovrebbe venire applicato a sé stesso).
Dante Maffia – dall’introduzione al libro “L’occhio e il mirino” (2013 – L’Arcolaio Ed.)
[…] Leggere la Massucco dunque è stato un piacere: mi ha fatto scoprire una dimensione inedita della parola, quel lievito che oscilla senza sosta per acciuffare il recondito fluire dei nessi, mi ha portato su un davanzale da cui ho potuto scrutare le movenze della perfezione divina nascosta a chi non sa guardare attraverso il mirino. Forse non aveva torto Baudelaire quando affermava che il lettore ha il diritto di trovare in un libro di poesia anche le cose che il poeta non sa di averci messe. Certo, il libro è complesso e variegato e devo dire comunque che mi è venuto incontro con il passo leggero di una ballerina avvisandomi da subito però che quel passo è frutto di lungo tirocinio, di passione sfrenata, di desiderio d’assoluto. Mi ha trovato pronto “l’armonia delle cose”.
Premio Nazionale di Poesia “Anna Osti” ed. 2012 – Commento della Giuria [Luca Pasello]
Capita raramente che con tanta sbarazzina levità un autore compia la più pesante e rischiosa delle operazioni: connettere parola e biografia (ma anche testo e dintorni, o la natura e il suo pensiero), celandone i nessi in superficie, dietro evidenze piane. Partiamo dall’elemento peritestuale, l’esergo alla prima poesia che dispone il lettore, lo addestra, ne estrae dal dizionario i valori connessi al lemma Austen – serenità di visione, sprezzatura, eleganza formale e, su tutto, una leggerezza conquistata per via di misura e stilizzazione (due corvi sulla balla di fieno: metafisica con juicio, ché divina in realtà è l’immagine dell’attimo). O moviamo, per prova, dalla biografia (tanto, sta tutta o quasi dentro l’opera, grazie a un io arditamente a giorno): studi di fisica acustica (mentore l’Eco di Ovidio? ci piacerebbe, e Narciso c’entra pure), buddhismo, il jazz e un marito (o viceversa). Manca un paio d’ingredienti ancora. Anzitutto il coraggio, quella dote da puella intelligente e spericolata che sa dire, in incipit: La rosa rampicante, ad esempio, non rispose più – ad esempio! E l’ironia per un privato Discours sur la méthode (vedi Thomson dentro il testo – o della-fisica-atomica-come-generatore-di-sguardi). E il brano di congedo, Polaroid in diminutio un po’ blasée: […] ero infinitamente bella | e spesso sbronza. Falsamente colti | un po’ arguti, gareggiavamo a parole e ricordi […]. Di più: Io a Firenze ci andavo per le fusa delle gatte | e la bici nel gelo – mica per il jazz. Sicura, Fosca Woodhouse?” (leggi l’intero articolo qui)
“La Bella Poesia” [Renato Fiorito]
“[…] Le poesie di Fosca Massucco sono caratterizzate da qualità inusuali e sorprendenti. Esse sono leggermente ambigue, nel senso che non sono mai chiuse in se stesse ma lasciano spiragli in cui l’animo del lettore può entrare di soppiatto; sono sfuggenti, poiché l’idea inizialmente suggerita viene spesso contraddetta dai successivi versi che, scientemente, ne cambiano il senso e la dimensione percettiva (Deve trovarmi pronta l’armonia delle cose / un gatto, un falò, un inverno / o pressappoco / prima che cambi idea); sono leggere, libere cioè di galleggiare sulla densità dei sentimenti, come accade a volte alle piume, quando volano sospese sul respiro di chi le guarda (Guardo fuori e aspetto quel sole / e quel vento – farò volare la cenere / e mi perdonerò.), lasciando poi ad ognuno la libertà di rincorrerle e, se ci riesce, di prenderle; sono multiformi poiché contengono in sé diverse potenzialità espressive (Sono stanca di essere stanca / cammino veloce attraverso i binari / schivando la voce che piove dall’alto. / Se sembro rapida nessuno intende la fatica, / se guardo interessata nascondo debolezza.); sono infine tenere, perché raccontano di un animo sensibile e amabilmente autoironico (Anche allora era settembre col temporale. / Aspettavo all’angolo un futuro / pieno di poetiche insulsaggini). Insomma sono bella poesia, difficile da trovare nella giungla delle tante parole senza qualità, ma arricchente e lenitiva del sommerso dolore quando finalmente la si incontra e la si riconosce. […]” (leggi l’intero articolo qui)